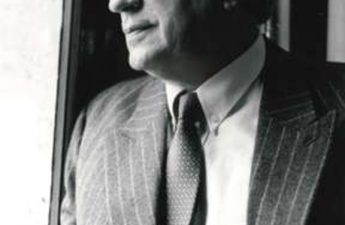Il 4 agosto scorso si è spento Vincenzo D’Alessandro (Bagheria 1934 – Palermo 2025), un protagonista di una stagione di rinnovamento della medievistica siciliana e italiana. Il suo nome è legato principalmente sia a un’opera che ha segnato profondamente la storiografia sulla Sicilia, il volume Politica e società nella Sicilia aragonese, apparso nel 1963, sia ai numerosi contributi sul regno normanno, fra i quali spicca il volume del 1978 Storiografia e politica nell’Italia normanna, che ripubblica e aggiorna con un nuovo lungo saggio (Fidelitas normannorum) studi apparsi fin dalla fine degli anni ’60.
Il suo magistero nell’Università di Palermo ebbe un breve inizio nei primi anni ’60 nell’ambito degli studi di storia moderna, ma si orientò prestissimo in campo medievale, nel quale proseguì fino ai primi anni 2000, lasciando un ricordo indelebile in molte generazioni di studenti, e accompagnandosi a un serrato dialogo con colleghi e amici della propria e di altre discipline che ne condividevano motivazioni intellettuali ed etiche. La frequentazione di figure della statura di Leonardo Sciascia e del conterraneo Ignazio Buttitta era stata peraltro parte importante della formazione di un pensiero storiografico segnato dal confronto con una rilevante tradizione intellettuale nonché dall’urgenza di un costante rigore etico.
In più occasioni all’impegno didattico e a quello di ricerca ritenne di dovere affiancare proposte di carattere sintetico e divulgativo, pubblicando sia agili volumi dedicati al pubblico studentesco, sia le mature sintesi di storia siciliana e meridionale del tardo medioevo apparse nella Storia d’Italia UTET (1989) e nei volumi de La Storia. I grandi problemi dal Medioevo all’Età contemporanea (1986).
L’opera complessiva di D’Alessandro può considerarsi un ripensamento di alcuni momenti fondamentali della storia siciliana coniugato allo sforzo di superare gli stereotipi storiografici che hanno a lungo condizionato la conoscenza della realtà medievale della Sicilia e del Mezzogiorno, intrattenendo anche un dialogo – a volte lealmente critico – con altri studiosi impegnati nello stesso senso come Giuseppe Giarrizzo, Giuseppe Galasso e Mario Del Treppo. In questa direzione sono andati i suoi studi sulla società urbana e sulle élites cittadine, sul ruolo degli uomini d’affari di origine centro e norditaliana immigrati nell’isola, sull’aristocrazia tardomedievale, sulle dinamiche politiche e sociali del Trecento siciliano. Come pure la costante attenzione al mondo rurale, oggetto di studi di lungo periodo e di indagini specifiche sul lavoro e sulla produzione, che oggi possono leggersi nel volume che volle pubblicare nel 2010 col titolo Città e campagne nella Sicilia medievale, virtualmente un seguito di quello pubblicato nel 1994 col titolo Terra, nobili e borghesi nella Sicilia medievale.
Su un altro versante, D’Alessandro si era dedicato fin dagli anni ’60 alla rilettura delle cronache di età normanna, per giungere a una revisione complessiva del tema normanno secondo la formula di “idea e realtà”, come intitolava un importante contributo a uno dei convegni del Centro Studi della Mendola, nel 1980. Gli importanti saggi precedenti e successivi su Amato da Montecassino, su Leone Marsicano e su Goffredo Malaterra sono percorsi dall’intenzione di leggere la vicenda del Mezzogiorno al di là della mitizzazione della conquista e del regno normanno.
Inevitabilmente, questi orientamenti lo hanno condotto anche a una continua attenzione alle dinamiche storiografiche della medievistica, alle quali ha dedicato numerosi e originali saggi, raccolti in volume sotto il significativo titolo I parenti scomodi (2005); in queste pagine, sia che parlino dell’antica storiografia erudita, sia che indaghino le vicende intellettuali e accademiche degli storici dell’Otto-Novecento, traspare l’intenzione di valorizzare, reinterpretandolo criticamente, il cospicuo e spesso insigne patrimonio storiografico accumulatosi nel tempo sui temi medievali siciliani.
Benché concentrate sui temi siciliani e meridionali, la curiosità intellettuale e l’intenzione di coordinare i suoi studi su quei temi agli sviluppi della medievistica italiana e internazionale lo portarono a partecipare con continuità ai maggiori incontri scientifici dove i suoi contributi riscossero sempre unanime apprezzamento per la loro lucidità e rigore metodologico; ciò gli consentì di tessere una rete di rapporti umani e scientifici che includeva gran parte della medievistica della seconda metà del Novecento; di particolare importanza, in questo ambito, il suo contributo all’attività del GISEM coordinato dall’amica di lunga data Gabriella Rossetti, dove D’Alessandro proponeva i suoi studi innovativi sulle relazioni fra Sicilia e realtà italiane.
Storico della società e del potere, D’Alessandro ha ispirato e stimolato gli studi di allievi diretti e indiretti, collocandosi a cerniera fra una generazione di storici che rifletteva sul conflitto fra i dominanti orientamenti etico-politici e le innovazioni della scuola francese delle Annales e una generazione che superava entrambe le egemonie culturali e apriva la strada alla storia sociale della politica e delle istituzioni, da D’Alessandro precocemente e praticata e coltivata con ininterrotta passione per i molti decenni della sua carriera di studioso e di Maestro.
Pietro Corrao
Ennio Igor Mineo